Ripropongo le precedenti 4 parti accorpate e senza modifiche.
***
Manie di grandezza. Fissazioni quantitative. Razionalità divorziata dalla teologia – quella vera – e sodomizzata dalla scienza e dalle sue misure. E’ così che nasce un mito: il Grande Inquisitore. Di cui oggi parliamo, in 4 puntate, con l’utopia di congedarcene definitivamente. Da bravi cattolici.
***
DE MONTICELLI: tutti in difesa dell’unicità

Nel passo che segue De Monticelli lo interpreta come l’avversario dell’unicità della coscienza. E non lasciamoci ingannare dal fatto che qui si depreca l’omicidio di Terry Schiavo – in altri testi la medesima autrice difenderà il diritto al suicidio di Welby -, perché appunto a dover esser difesa non è la verità in quanto essa può e deve mantenere di oggettivo e condiviso, ma solo il primato indiscutibile della coscienza del singolo.
Del racconto di Dostoevskij si prende l’inciso: “Invece di solidi fondamenti capaci di tranquillare la coscienza dell’uomo una volta per sempre, Tu hai voluto che con libero cuore… l’uomo scegliesse lui stesso cosa fosse bene e cosa fosse male”, da cui si traggono le considerazioni congruenti:
L’attualità di questa pagina si constata ogni volta che si vede quanto facilmente l’opinione pubblica si lascia guidare dell’Ideologia, il cui mestiere (di qualunque ideologia si tratti) è precisamente quello di fornire soluzioni bell’e pronte, evitando il faticoso esercizio della facoltà di discernere. (p. 102)
Salta agli occhi il bisogno di generalità assertorie, che persino in un caso come questo la vince sulla percezione dell’individualità e dell’unicità di un semplice smarrito volto umano.
Il Grande Inquisitore ride trionfando (p. 104)
Roberta De Monticelli, Nulla appare invano, Baldini Castoldi Dala, Milano 2006.
***
MANCUSO: l’importante è prendere Roma

Nel suo Obbedienza e libertà, Mancuso dedica al nostro un intero capitolo, La teologia politica del Grande Inquisitore, in cui viene messo alla sbarra il “delicato rapporto tra potere ecclesiastico e verità”, dalla disamina storica del quale emergerebbe che
la repressione della libera ricerca della verità è stata un elemento costitutivo non solo dell’istituzione Chiesa in quanto fenomeno sociale e politico, ma anche della configurazione della sua dottrina e della sua spiritualità. (p. 48)
Vito Mancuso, Obbedienza e libertà, Campo dei fiori, Roma 2012.
In questo caso il cardine argomentativo sta nella ricostruzione delle forze che reggono il cattolicesimo:
Esistono sulla terra tre forze, le uniche tra forze capaci di vincere e soggiogare per sempre la coscienza di questi deboli ribelli al fine di renderli felici – sono il miracolo, il mistero, l’autorità. (pp. 50-51)
Ovviamente il Gesù del romanziere russo ha rifiutato tutti e tre le risorse, differentemente dall’Inquisizione cattolica. Il Grande Inquisitore di Mancuso, forse anche a ragione della posizione anomala e della sensibilità peculiare di questo ex sacerdote ambrosiano, è un’icona dell’anti-romanità per eccellenza; senza neppure più le sfumature filosofiche universali della lezione eccentrologica demonticelliana. A ragione Mancuso riconosce che nella Catholica vige “il principio autorità”, a torto lo considera dialetticamente alternativo (ricordiamo che Mancuso esordisce come teologo hegeliano) alla verità e alla libertà.
Specularmente si ricava il senso e la missione di Gesù di fronte a questo truce Giudice terreno. Si prende a criterio ermeneutico il parere dell’ateo Ivan:
Se davvero ce la farò ad amare, sarà soltanto nel tuo ricordo. Mi basterà sapere che sei qui, da qualche parte, e non vorrò ancora smettere di vivere. (p. 53)
E si traggono le fila della questione:
La vera fede in Dio deve fare solo questo, stare accanto agli uomini e ricordare con la propria vita e con il minor numero di parole possibili che questa esistenza può avere un senso e che questo senso è l’amore, e generare così nelle anime sfiduciate voglia di vivere. (Ibidem)
La vera fede è quella degli atei; ha la funzione di un antidepressivo (un Malox teologico); vive di silenzi (che Mancuso nella sua grafomania subito tradisce); consiste in un auto-convincimento francamente né solido né sicuro.
Ovviamente, poste simili premesse, non possono che venirne pessime conclusioni. L’autore lo riconosce.
L’opposizione sistematica tra libertà e appartenenza alla Chiesa Cattolica, dichiarata da Dostoevskij, durante il Novecento si è andata dilatando, e ha generato la diffusissima idea di una opposizione sistematica tra libertà ed esperienza spirituale. Occorre sfatare questo luogo comune.
Eh già, non è che occorra confutare l’invenzione letteraria anti-romana dello scrittore ortodosso, prospettiva parziale e forzata dalla cui menzogna – come da ogni menzogna – derivano frutti marci; no, bisogna tenere l’odio anti-cattolico, ma salvare il resto. Lasciamo l’eretico Mancuso a questa sua fatica disperata, senza manco più la soddisfazione di poter attestare la propria sincerità nella forma eroica di qualche rogo – no, a lui resti solo l’attesa annoiata della teologia del Malox.
***
CACCIARI: teologia politica, katechon e mitomanie

E infine un terzo autore, curiosamente anche lui approdato all’Ateneo del San Raffaele, più intrigante dei precedenti: Massimo Cacciari. Trovo una sua lettura del Grande Inquisitore incastonata nella riflessione teologico-politica sul katechon. Il katechon, il potere che frena, al confine tra Cristo e Anticristo, è lì che si colloca l’Inquisitore. Delle tre, certamente la lettura più profonda e radicale, comunque aperta all’idea che il freno demorderà, e che allora l’Apostasia potrà dilagare.
L’anticristicità che l’Inquisitore professa è rigorosa. (p. 102)
Non nega la divinità del Cristo. Ma nega il Cristo punto e basta.
L’anticristicità diviene per lui condizione dell’agire catecontico. (p. 103)
L’unico modo per frenare l’Apostasia è frenare Cristo. Cristo infatti è la causa di quel declino che porterà all’Apostasia.
E’ dal nomos della croce che una tale energia si sprigiona inesorabilmente. Quel nomos spalanca l’abisso della libertà in cui l’uomo, insalvabile in-fante, non può che precipitare. (Ibidem)
In alternativa si concepisce l’azione dell’Inquisitore
Egli impersona il movimento per cui il katechon si supera… Katechon si traduce per lui in potere coercitivo, aperto a nulla, poiché in nulla si trascende, in nulla è redimibile, la natura stessa dell’esserci. (p. 104)
Questa disperazione circa la redimibilità dell’uomo produce una simile figura storica – L’inquisitore non è un legatus dell’Antikeimenos, “viene da noi” (p. 105) – che sta dalla parte dei dèmoni proprio fingendo di esserne il più radicale oppositore. (p. 104).
Ovviamente l’Inquisitore è destinato a fallire. Incapace di “ritardare” l’effetto cristico dell’esasperazione della libertà, si scopre sempre e solo “in ritardo”, e comunque sottoposto al giudizio spiazzante di Cristo nel Suo bacio. (cf. p. 106)
Nulla intuisce di poter fare per arrestare il giudizio. Esso verrà, e gli suonerà profondamente ingiusto. Perché il metro su cui verrà formulato è per lui profondamente estraneo alla natura dell’uomo e della sua storia. (p. 107)
M. Cacciari, Il potere che frena, Adelphi, Milano 2013.
Cacciari è d’accordo con De Monticelli: l’Inquisitore ha paura della libertà anomica suscitata dal proto-rivoluzionario Cristo.
Mancuso invece si perde nelle secche di un’apologetica anticattolica molto superficiale e strumentale.
***
SCHMITT: una via di uscita, dalla giustizia alla gloria
.jpg)
Sui tre autori però urge imporre la lettura virile di Carl Schmitt. Virile e soprattutto cattolica, cioè capace di penetrare l’intenzionalità cattolica e di leggerla in se stessa, e non invece enfatizzandone in modo artefatto le sbavature.
Il grande tradimento che si imputa alla Chiesa Romana è proprio che non concepisce Cristo come un privato né il cristianesimo come affare privato e puramente interiore, facendone anzi una istituzione formale e visibile. (p. 63)
Fatti saltare la De Monticelli e Mancuso in tre righe e un toc, Schmitt può dedicarsi a una demolizione ante litteram di Cacciari.
Come ogni imperialismo universale, anche la Chiesa, se consegue il proprio fine, porterà al mondo la pace, ma appunto in ciò una paura ostile alla forma vede la vittoria del demonio. (Ibidem)
La soluzione radicale è sconfessare Dostoeskij, grande genio, riportando in primo piano la questione prima: il prosatore russo non è cattolico, non ragiona da cattolico e non capisce il cattolicesimo. Ben che vada vi proietta sopra i suoi propri sospetti ortodossi e anti-romani, mal che vada vi proietta di peggio.
Qui Dostoevskij, con grande violenza, ha proiettato sulla Chiesa cattolica il proprio potenziale ateismo. Per il suo istinto fondamentalmente anarchico — che è sempre ateo — ogni potere era qualcosa di malvagio e d’inumano. (p. 64)
Schmitt stesso riconosce i rischi insiti nell’esercizio di potere ecclesiastico, ma pure guarda oltre, guarda al valore che tale potere rappresenta e tutela semplicemente essendo se stesso.
Nella dimensione temporale la tentazione del Male, che è presente in ogni potere, è senza dubbio perenne, e l’opposizione fra bene e potere è superata, senza residui, soltanto in Dio; tuttavia, il volersi sottrarre a quell’opposizione, rifiutando ogni potere mondano, sarebbe la peggiore inumanità. (Ibidem)
Ciò posto, bisogna pur fare i conti con la totale distorsione della razionalità delle masse, con l’imporsi di un gusto psicologico e culturale che tende pervicacemente a fraintendere il cattolicesimo, anche a costo di insistere su letture grottesche del Cristo.
Una sensibilità oscura e ampiamente diffusa sente la freddezza istituzionale del cattolicesimo come malvagia, mentre l’informe enormità di Dostoevskij è percepita come vero cristianesimo. Ma ciò è banale, come tutto quello che resta prigioniero della sensibilità e della sensazione; e non si vede neppure quanto poco cristiana sia la teoria che Cristo — fra la Sua esistenza terrena e il Suo glorioso avvento il giorno del Giudizio — possa apparire una o più volte fra gli uomini, per così dire a mo’ d’esperimento. (Ibidem)
Che dunque? Dovremo arrenderci all’alternativa sterile tra un gout dé modernité ciecamente anti-cattolico, e una ripetizione del secco imperativo giuridico dei romani? No, Schitt va oltre. E propone un anti-dostoevskij, un autore alternativo, non meno acuto ma più veracemente petrino.
Con maggior concisione di Dostoevskij e tuttavia con una latitudine d’orizzonte infinitamente più ampia, lo spirito di un cattolico francese ha inventato un’immagine che racchiude tutta la tensione di quell’antagonismo fra giustizia e splendore glorioso e che contemporaneamente (con la formulazione di un appello rivolto contro il giudizio di Dio) spinge dialetticamente la giustizia all’estremo, conservando la categoria giuridica proprio con l’introdurre formalmente una sentenza e un appello. Ernest Hello ha avuto il coraggio di dipingere un’incredibile scena del Giudizio universale: una volta che il Giudice del mondo ha emesso la propria sentenza, un dannato, carico di delitti, se ne starà fermo e, fra l’orrore dell’universo, dirà al giudice: «j’en appelle». «A queste parole si spengono le stelle». Ma nell’idea del Giudizio universale è implicito che le sue sentenze siano assolutamente definitive, «effroyablement sans appel». «A chi ti appelli, contro il mio giudizio?», gli chiede Gesù Cristo, il Giudice; in un tremendo silenzio il dannato risponde: «j’en appelle de ta justice à ta gloire». (p. 65)
C. Schmitt, Cattolicesimo romano e forma politica, Il Mulino, Bologna 2010.
C’è una buona notizia per tutti: di Dostoeskij si può fare a meno. E del Grande Inquisitore, di Cacciari, Mancuso, De Monticelli. E si può essere fieramente ed autenticamente cattolici. Oggi e “di oggi”.

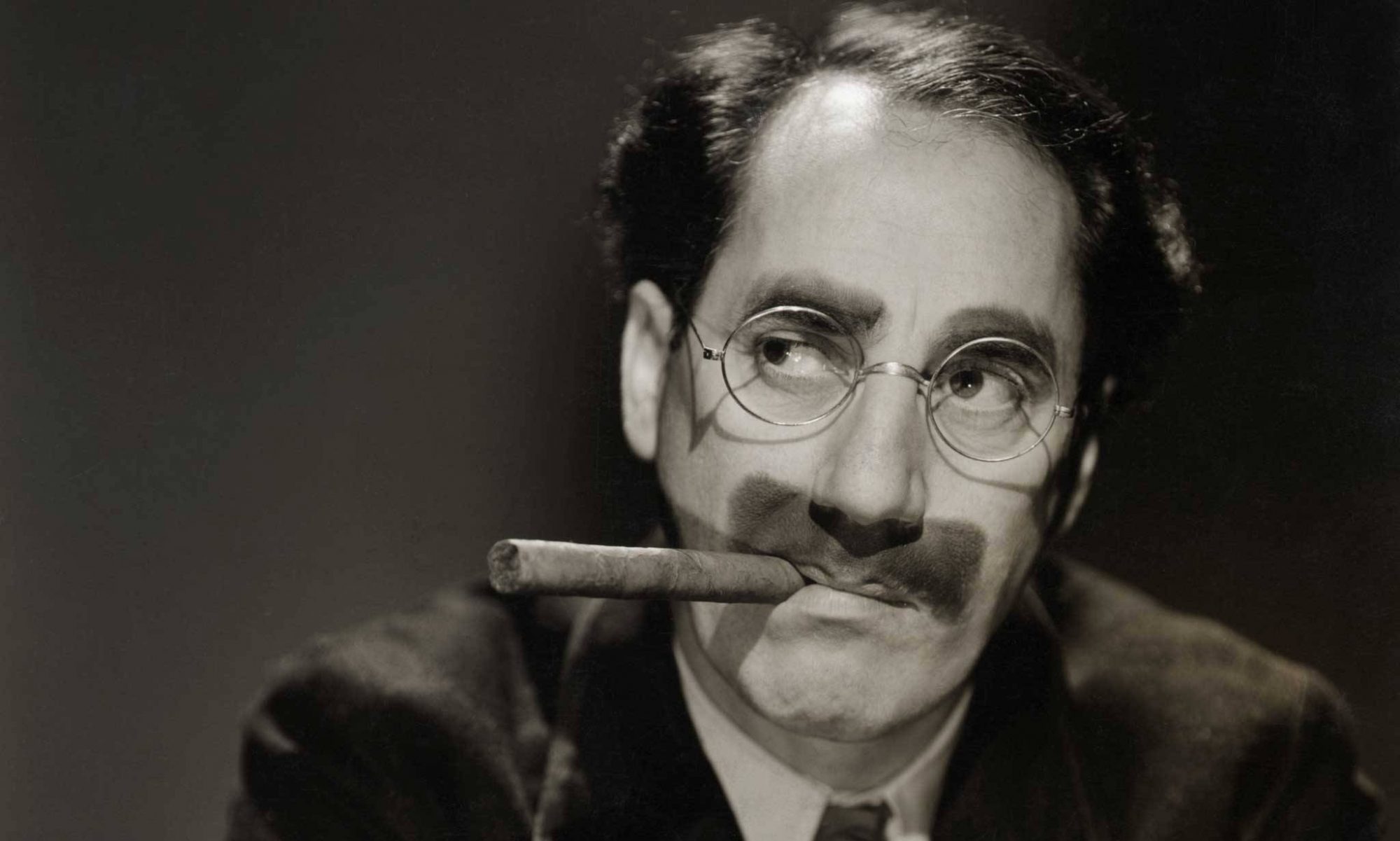




.jpg)