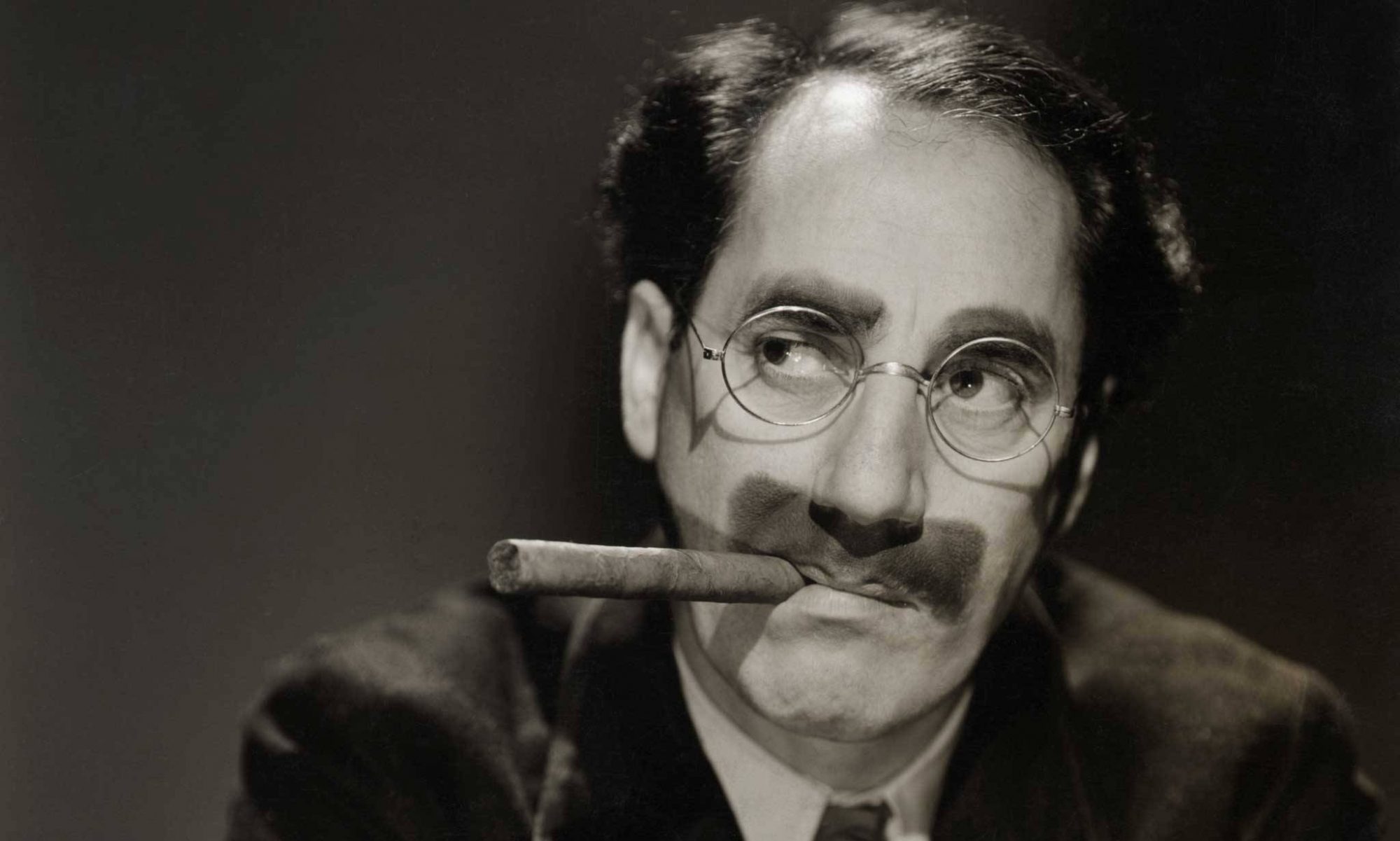Primo step. I grandi registi si vedono dai piccoli dettagli, e il piccolo dettaglio nei film basati sul concetto di sacrificio è la croce. In “The Passion” la croce è un tronco scheggiato cui il Cristo si aggrappa in un abbraccio scandaloso d’amore; in “Cristiada” la croce è un monile che il colonnello ateo lascia sul fondo di un bicchiere di whisky (o simili) per ricordare al dittatore ateo che almeno la libertà, almeno quella, va garantita sempre e a tutti (come il buon whisky, suppongo); in “Apocalypto” la croce è quella del frate, nella scena finale, quando la scialuppa si stacca dalle caravelle e approda alla costa e, certamente, il frate che la regge è un idiota senza coscienza, ma si intuisce che quell’idiota, portando la croce, toglierà il giogo dei sacrifici umani; in “Hateful Eight” la croce è una scultura di pietra che domina tre minuti di ripresa sotto un pesante strato di neve; in “Silence” è un artefatto in legno nascosto in una bara in fiamme.
Ora, “The Passion” è un film epocale, dove finalmente la croce è stata rappresentata e non solo romanzata; “Cristiada” è un film godibile, impreziosito più dal soggetto politicamente scorretto che da una suprema regia, ma di sapore forte e barricato, come un buon whisky (o simili); “Apocalypto” è onesto, ha capito che non si poteva dire in un film il prodigio della conversione latino-americana, anche perché dovuta a Guadalupe e non tanto ai missionari, e dunque ha detto poco, appena accennato. Restano Tarantino e Scorsese. Il primo sufficientemente nichilista e risoluto da potersi permettere di immortalare le cose come stanno: l’umanità senza Dio, un carnaio di corpi dilaniati e impallinati, destinati a decomporsi non appena la conserva invernale verrà meno; la religione, un concentrato di simboli sempre eloquenti e sempre muti, pietrificati, posti ai crocevia della vita, capace però di sopravvivere a stagioni e a carovane, a mode e a discorsi umani troppo umani.
Il secondo, ahinoi, cattolico, di quel cattolicesimo slavato di modernismo in nome della coscienza, per cui incapace sia di grandi gesta religiose sia di grandi gesta irreligiose: la fede è la codardia di un apostata troppo piagnucoloso per risolversi contro Cristo e troppo intellettualoide per risolversi per Cristo (ripeto: intellettualoide, a confronto col compagno di spedizione dimostra di mancare sin delle basi della teologia tridentina, che pure è semplice), non avendo accettato l’obbedienza “perinde ac cadaver” conclude la sua parabola abiurale da cadavere e si trova in mano un piccolo crocifisso di legno destinato a finire in cenere con lui, evidentemente concessogli come inutile amuleto da pietosi buddisti mai convertiti (la moglie di un altro che non si è scelto, mentre si era scelto la vocazione religiosa), sì che col prete fallito si realizza davvero lo spauracchio ventilato dal suo cedevole maestro (Ferreira): aver ridotto il Vangelo a una nuova superstizione nipponica, senza radici e senza futuro – appunto prigioniera del presente vuoto della coscienza.
Secondo step. I grandi registi sono immortalati dai loro film. Gibson confeziona due pellicole in poco tempo, nelle quali esprime un pensiero continuativo: chi è Cristo per me, chi è la Chiesa per me. Messaggio complessivo: Cristo è colui il cui sacrificio, perpetuato dalla Chiesa, estingue i sacrifici del mondo. Anche Scorsese fa il filotto, più nella forma di una inclusione, per cui la sua vasta produzione si vede coerentemente incorniciata tra “The last temptation of Christ” e “Silence”. Anche qui si risponde a due domande: chi è Cristo per me, chi è la Chiesa per me. Il Cristo di Scorsese era un fantoccio nevrotico, delineato sugli schizzi delle tradizione gnostica, la Chiesa di Scorsese è un feticcio in decomposizione pericolante sui residui della rivoluzione modernista (con tanto di gesuiti luteranizzanti). Il Cristo di Scorsese non comprende nulla del Padre e solo per un macchinoso colpo di scena finale accetta di salire in Croce, agisce mosso da costrizioni esterne e non da motivazioni interiori, si accorge di essere stato preso in giro; la Chiesa di Scorsese non comprende nulla di Cristo, i suoi consacrati scelgono la missione per ragioni umane – ritrovare un amico (i.e. salvate il soldato Ryan) -, non interiorizzano il senso dell’evangelizzazione, fraintendono completamente il valore della fede popolana e da ultimo, nell’impossibilità registica di elaborare un nuovo macchinoso colpo di scena finale, soccombono e, nella loro apostasia mai radicale, prendono in giro tutti. E si capisce!, rifiutano di agire per ossequiare al formalismo, seguono la propria coscienza puramente soggettiva, che li consegna all’unica cosa cui essa può consegnarci, al torbido eterno ritorno senza identità e senza utilità (il buddismo è il miglior alter-ego esoterico di tale annichilazione all’occidentale). Però, e di nuovo, troppo debole per saltare al vero nichilismo e troppo orgoglioso per accettare il cattolicesimo: a bientot, Nietzsche. Preferisco Tarantino, che almeno fa una scelta netta. In entrambi i casi, noto en passant, i protagonisti di Scorsese sono dei capelloni, barbettati e frignanti. In entrambi i casi, noto en passant, il Cristo e la Chiesa di Scorsese sono messi in scena a partire da romanzi e non dalla storia né dalla Rivelazione.
Terzo step. Una riflessione su Scorsese: cosa cambia a livello ecclesiologico tra “The last temptation” e “Silence”? Perché lì alla fin fine ci si piega all’osservanza esteriore della tradizione e qui ci si abbandona definitivamente alle maschere nicciane della coscienza? C’entra forse il mutato regime romano, ieri ancora capace di direttive magisteriali e oggi aperto al liberalismo teologico? Oppure, al contrario, non è che il mutamento romano abbia ispirato Scorsese, è che Scorsese, da grande artista, è davvero espressione (tragica) del suo tempo (tragico) e, persino, dell’evoluzione religiosa cattolica dell’ultimo cinquantennio. Sia come sia, la voce narrante conclude nel più francescano dei modi: solo Dio può giudicare – tra preti sepolti con rituali di bonzi e con l’eco di quel “padre Francesco” (Ignazio non ricordo se lo nominino) che al popolino ricorderà più che altro Assisi. Altro dettaglio da maestro, aver a suo modo descritto il ruolo unico del sacerdozio nell’irradicare il cristianesimo in una terra pagana: peccato averne poi celebrato l’abiura. Anche qui, spero sia solo per paranoia, vedo temibili parallelismi romani. E da ultimo, su Scorsese, questo elegante elogio della coscienza “absoluta”, questa esaltazione di una religiosità concreta da non giudicare, così in sintonia con le svolte pastorali concrete, coi capricci della coscienza credente, con le abiure almeno materiali della tradizione matrimoniale in casa cattolica… geniali conincidenze. Mi fermo, non senza ricordare che parlare di “Silenzio” di Dio in un film, in cui “de facto” il vero dio è il regista, impossibilitato a tacere sia pure per un solo momento, ha un che di paradossale e curioso.
Quarto step. Una riflessione su don Malatacca. Non so proprio chi possa essere don Malatacca, ma trovo il suo commento a “Silence” su Aleteia. Urgono un paio di osservazioni. La prima: prometto essere l’ultimo commento di un religioso allineato che oso leggere, dato che al prossimo sfoggio di modernismo politicamente corretto con tante sbavature teologiche e tante forzature ermeneutiche (contro la storia, forse anche contro il film-romanzo) rischio di abiurare. La seconda: il prete foggiano scrive che “i contadini sono semplici, chiedono segni tangibili di fede forse più della fede stessa, perché hanno bisogno, la loro fede è “a tatto”, ma è vera. Per una coscienza semplice calpestare un segno della fede è essenziale, è abiura o martirio; è come se calpestassero il Signore in persona”. E per un prete la fede è astratta? I segni della fede non gli sono essenziali? Nel momento in cui l’inquisitore chiede di bestemmiare il nome della Vergine (la frase campeggia nei sottotitoli dei cinema di tutto il mondo, ma io non ho il coraggio di riprodurla), il contadino non può farlo, mentre il prete sì? Ah beh, siam messi proprio bene e capiamo tante cose sul clero odierno. E poi, quello di padre Rodriguez, checché ne dica il Malatacca, non è un martirio – “Ha vissuto un martirio di vergogna, continuo, per non rinnegare il suo Signore” -, ma è la punizione per una scelta sbagliata, è un castigo divino (nel senso teologico del termine, un’auto-punizione che l’uomo si infligge, quando si ribella alla Verità).
Insomma, al solito i commenti della Chiesa sbragata sono peggio dei film di grido, sempre in ansimo per difendere l’indifendibile e per salvare tutto e tutti, tranne ciò che attiene agli imperativi del Cristo. Quanto a me, preferisco il Suo silenzio oggi alla sua condanna domani. E ora attendiamo il nono film di Tarantino, per risollevare lo spirito